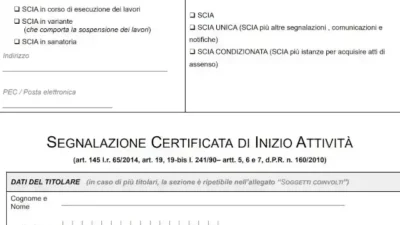Consiglio di Stato ammette verifiche tardive sulle SCIA, precisando condizioni per agire in autotutela oltre i termini
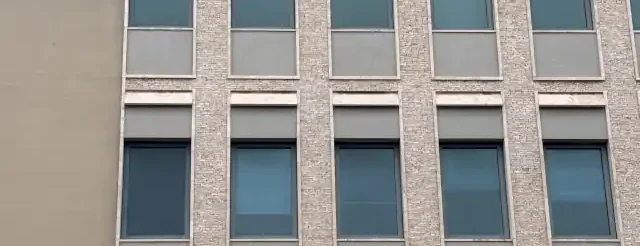
Quando e come il Comune può emanare ordinanze di demolizione e dichiarazioni di inefficacia verso SCIA e CILA?
Un altro chiarimento arriva dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 6322/2025, specificando le distinzioni tra i due istituti. Partiamo prima dai riferimenti normativi:
- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), prevista dall’articolo 6-bis DPR 380/01;
- Segnalazione Certificata Inizio Lavori (SCIA), di ambito edilizio, disciplinata dagli articoli 22 DPR 380/2001 e 19 L. 241/1990. A tal proposito, a livello generale il procedimento amministrativo generale è regolato dalla L. 241/90, a cui sono stati affiancati speciali previsioni integrative previste dal testo unico edilizia;
Il riordino generale sulla CILA è stato effettuato con D.Lgs. 222/2016, e nel frattempo il Consiglio di Stato si era espresso con il proprio parere n. 1784/2016, affermando che non sia possibile applicare alla CILA il medesimo regime giuridico espressamente previsto in relazione alla SCIA. In quella sede, con riferimento alla CILA, il C.d.S. affermò che occorre partire dal dato incontrovertibile per cui manca nella normativa vigente qualsiasi riferimento ai poteri spettanti all’Amministrazione a seguito della comunicazione asseverata del privato. Infatti, in merito alla CILA la norma non prevede alcuna attività di controllo, al netto di quelle controllate per sorteggio e in rapporto alla legislazione regionale, che sia espressione dei poteri inibitori e di secondo grado, previsti invece nel caso della SCIA, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 19 L. 241/1990. Più precisamente, per la CILA di cui all’art. 6-bis TUE, ha previsto espressamente i soli poteri sanzionatori spettanti alla P.A. per il caso in cui il privato inizi i lavori senza aver previamente presentato la CILA; non sono previsti, viceversa, poteri di controllo (siano essi repressivi, inibitori, conformativi, inefficacia ovvero di autotutela) come nel caso di SCIA.
Al contrario, la normativa si limita a prevedere una sanzione pecuniaria di 1.000 euro per l’ipotesi di mancata comunicazione (art. 6-bis, comma 5, t.u.ed.) o di 333,33 euro per tardiva presentazione con lavori avviati, demandando alle Regioni a statuto ordinario la disciplina «delle modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco» (art. 6-bis, comma 4, t.u.ed.).
Ancora oggi il testo unico non chiarisce se l’assenza della previsione, in caso di CILA, di un potere di controllo (inibitorio) amministrativo costituisca una mera lacuna del legislatore (colmabile, magari, mediante applicazione analogica delle regole previste per la SCIA) o sia espressione della chiara intenzione di quest’ultimo di diversificare sul punto i regimi dei due titoli abilitativi in questione.
Il problema sui limiti della CILA era emerso anche per quelle espressamente previste dalla CILAS, cioè quella CILA superbonus, ai sensi dell’articolo 119, 13-ter, D.L. 34/2020: sulla questione dei poteri di annullamento e dichiarazione verso la CILAS, e delle CILA, si sono alternati pronunce e orientamenti opposte.
Inoltre, il Consiglio di Stato si era già espresso a favore della dichiarazione di inefficacia della CILA, mutuando gli stessi strumenti e criterio applicati per la SCIA (Consiglio di Stato sentenza n. 4110/2023).
Secondo la recente sentenza n. 6322/2025 del Consiglio di Stato, la diversa formulazione normativa prevista per la CILA non appare frutto di una dimenticanza del Legislatore e non consente, dunque, il ricorso all’interpretazione analogica, applicando cioè gli stessi poteri di controllo e procedurali previsti per la SCIA.
Ciò significa che la CILA ha solo una funzione informativa nei riguardi della pubblica Amministrazione circa l’avvio dei lavori (pur sulla scorta di un progetto asseverato) da parte del soggetto privato, con la conseguenza per cui le conseguenti verifiche dell’Amministrazione saranno limitate al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale. In altri termini:
- nella SCIA, la sostituzione del paradigma autorizzatorio con una segnalazione privata viene compensato attraverso un controllo a posteriori che si esplica nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei poteri inibitori e di autotutela, così come espressamente declinati all’art. 19, L. n. 241/1990;
- nella CILA la liberalizzazione dell’attività acquista un grado di autonomia ancora più marcato.
L’attività assoggettata a CILA non solo è libera (edilizia libera ma soggetta ad asseverazione comunicata), come nei casi sottoposti a SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, mentre deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio (vedi in tal senso, cfr. il cit. parere del Consiglio di Stato n. 1784/2016). Per la CILA, in assenza di espressi poteri inibitori o di autotutela, la P.A. potrà e dovrà solo verificare l’effettiva corrispondenza dei lavori (iniziati) a quelli consentiti tramite CILA, e questa è la distinzione più rilevante tra gli istituti della CILA e della SCIA.
In tal senso è del resto orientata anche attenta dottrina, secondo la quale, entrambi gli istituti presentano la medesima natura giuridica e le stesse finalità «ma si declinano in manifestazioni diversificate del potere amministrativo: nella segnalazione certificata più strutturato, nella comunicazione asseverata più attenuato, quasi etereo».
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6322/2025, ha ritenuto quanto sopra maggiormente condivisibile e coerente con il principio di legalità, che costituisce il fondamento ed il limite dell’intera attività amministrativa, anche di quella che si esprime con l’adozione di provvedimenti di secondo grado.
In tale direzione appare orientata anche la giurisprudenza costituzionale, che, con la recente sentenza 2 luglio 2025, n. 88, superando la tradizionale prospettiva che riteneva il potere di autotutela espressione dello stesso potere esercitato in primo grado (o di un potere implicito che da questo derivava), di cui condivideva il carattere di inesauribilità, ha autorevolmente ribadito l’importanza della stretta osservanza del principio di legalità in relazione ai poteri di secondo grado, osservando, in particolare che “Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta “supremazia” (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua “inesauribilità”, nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.)».

Seguimi dal canale Telegram
Conclusioni
Il Consiglio di Stato con questa recente pronuncia giunge alle seguenti conclusioni sulle differenze dei regimi di controllo, repressivi e sanzionatori tra CILA e SCIA, convalidando le posizioni espresse sopra, in quanto:
- appare più coerente sul piano sistematico, perché attribuisce all’istituto della CILA una autonomia concettuale e funzionale rispetto all’istituto della SCIA dal quale, diversamente opinando, stenterebbe a differenziarsi;
- La evidenziata diversità tra i regimi normativi della SCIA e della CILA non esclude, tuttavia, che debbano ritenersi operare, anche in relazione alla CILA, pur sempre i poteri di vigilanza spettanti, ai sensi degli artt. 27 ss., d.P.R. n. 380/2001, alla P.A. al ricorrere di ipotesi di abuso, e ciò sia a valle di una istanza del terzo, sia d’ufficio, con la conseguenza che anche nella CILA permangono forme di esercizio di potere repressivo da parte dell’Amministrazione, ancorché non coincidenti (e non identicamente individuate, finanche sotto il profilo lessicale) con quelle previste per la SCIA ordinaria, dall’art. 19, L. n. 241/1990;
- Da quanto in precedenza osservato discende che, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 27, del d.P.R. n. 380 del 2001, l’Amministrazione comunale può certamente dichiarare l’inefficacia della CILA quando essa viene utilizzata per legittimare interventi che avrebbero richiesto una SCIA o un Permesso di Costruire e, dunque, nel caso di CILA radicalmente difforme dal suo paradigma legislativo.
In altre parole, al Comune restano altri poteri e strumenti repressivi contro gli illeciti edilizi compiuti col supporto della CILA, primo tra tutti le ordinanze di sospensione lavori e di rimessa in pristino previste dall’articolo 27 DPR 380/01. Non bisogna neppure dimenticarsi dei poteri repressivi e sanzionatori previsti a livello penale quanto l’opera asseverata, iniziata o conclusa con la CILA si ponga in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia, vincoli e norme di settore, perchè l’articolo 44 del DPR 380/01 vale anche per interventi edilizi apparentemente minori.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Abitabilità e Agibilità rilasciate non sana abusi, regola ed eccezioni
- Variante al Piano Regolatore e ruolo nella sanatoria edilizia
- Meglio sanare anche irregolarità astrattamente qualificabili come tolleranze
- Quando possono annullare permesso di costruire oltre 12 mesi dal rilascio, Corte Costituzionale conferma
- Firenze, il cubo bianco-nero e armocromia edilizia
- Soprintendenza non può ordinare demolizione abusi edilizi, conferma dai TAR